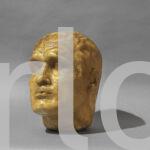| OPERA DISPONIBILE

Emanuele Cavalli
Lucera 1904-Firenze 1981
Ritratto della matematica Mary Catherine Bishop Weiss (Wichita, Kansas 1930 – Chicago 1966) • 1961
Olio su tela, 70,5 × 87 cm
Firmato e datato in alto a destra: “E. Cavalli”; firmato e datato sul retro: “E. Cavalli/1961”; sul telaio: “E. Cavalli – luglio 1961”
Esposizioni: Emanuele Cavalli: mostra antologica, Firenze, Galleria d’Arte Santacroce, 20 gennaio – 2 febbraio 1962.
La figura di Emanuele Cavalli è oggi oggetto di un rinnovato interesse da parte degli studi, che hanno finalmente riconosciuto il peso del suo contributo al dibattito artistico italiano del periodo tra le due guerre: non soltanto in qualità di pittore e protagonista della Scuola romana, ma anche come fine sperimentatore in ambito fotografico. Firmatario, insieme a Giuseppe Capogrossi e Roberto Melli, del Manifesto del Primordialismo Plastico del 1933, Cavalli esercitò un’influenza profonda sulle ricerche figurative sviluppatesi a Roma tra gli anni ’30 e ’40, grazie a una personale concezione del fare pittura a cui rimase a lungo fedele. Centrale nella sua poetica è il concetto di “tono”, che assegna al colore il duplice compito di evocare suggestioni musicali e di strutturare volumi, forme e profondità. Sul piano iconografico, Cavalli si mantenne sempre entro l’alveo della tradizione figurativa: ritratti, figure, nudi, paesaggi e nature morte scandiscono l’intera sua produzione, spesso pervasa da allusioni all’universo esoterico, di cui era profondo conoscitore. Determinante, nella definizione del suo linguaggio visivo, fu inoltre lo studio e la rielaborazione personale della storia dell’arte: lo si evince dai molti rimandi alla pittura parietale romana – in particolare agli affreschi della Villa dei Misteri di Pompei – e agli stilemi del Quattrocento italiano, soprattutto a Piero della Francesca, che si rilevano nelle sue composizioni.
A tale visione rimase ancorato anche dopo il trasferimento definitivo a Firenze, avvenuto nel 1946, quando fu nominato titolare della cattedra di pittura presso l’Accademia di Belle Arti lasciata dal maestro Felice Carena. Da quel momento, la sua partecipazione alla scena artistica contemporanea si fece volontariamente più defilata, e mentre l’arte italiana si rivolgeva con sempre più interesse verso le istanze d’avanguardia statunitensi, Cavalli proseguì nella sua indagine sui valori tonali della pittura. All’inizio degli anni Sessanta, la sua ricerca fu attraversata da una crisi personale che si rifletté in un pennellare nervoso, un segno zigzagante, nel ricorrere di linee serpentine e nella rappresentazione di figure allungate e stilizzate. Un mutamento, questo, che emerge già nel ritratto in esame, eseguito nell’estate del 1961. L’effigiata è Mary Catherine Bishop, matematica statunitense dalla brillante carriera accademica – docente alla DePaul University, alla Washington University e alla University of Illinois, oltre che collaboratrice della Cambridge University in un importante progetto di ricerca – moglie del matematico Guido Weiss. Quest’ultimo, figlio del celebre psicoanalista Edoardo Weiss, era cugino di primo grado di Vera Haberfeld, moglie di Cavalli. La personalità e il fascino magnetico di Mary Weiss, trentenne all’epoca del ritratto, colpirono profondamente l’artista pugliese, che la immortalò in diversi scatti fotografici e in almeno tre dipinti noti, tutti realizzati nel corso di poche settimane. Tra questi, l’opera qui si presentata va senza dubbio ritenuta come la più significativa della serie.
La donna è rappresentata seduta a un tavolo: le mani, dalle dita lunge e affusolate, sono messe in evidenza; con la destra regge una brocca, mentre con la sinistra, in un gesto fortemente evocativo, porta a sé una delle sette uova disposte sul piano. Il motivo dell’uovo, elemento geometrico essenziale, è ricorrente nella produzione di Cavalli, tanto in pittura quanto in fotografia: memore della Pala di Brera di Piero della Francesca, si carica di significati allusivi all’inconscio e alla sfera femminile. Lo schema compositivo delle uova sul piano rimanda inoltre a precedenti cavalliani come la grande tela Donne, premiata alla Quadriennale del 1935 e andata in gran parte distrutta durante l’alluvione del 1966, dove l’artista aveva concepito la composizione come uno spartito musicale, con le figure – anch’esse in numero di sette, come le uova nel quadro in esame – distribuite secondo una scansione ritmica assimilabile a quella del pentagramma.
La genesi del ritratto di Mary Weiss è riferita con puntualità nel diario dell’artista, tuttora inedito, conservato nel “Fondo Emanuele Cavalli” dell’Archivio della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. L’elaborazione del dipinto ebbe inizio il 19 luglio del 1961, quando Cavalli ne tracciò il disegno preparatorio: «Mary pensava per una figura con un coniglio», annotava, documentando così il coinvolgimento diretto della modella nella definizione della composizione; «Per ragioni plastiche e per il poco tempo a disposizione abbiamo deciso di fare una figura con natura morta». Il giorno seguente l’opera risultava già in fase avanzata. I successivi appunti del diario, qui riportati integralmente, restituiscono la vivacità del processo creativo, scandito da dubbi, modifiche e intuizioni improvvise:
20 luglio: «Tela 70 x 85. Fondo violaceo piano grigio giallo. Figura in giallino. Poggia una mano su di un vasetto scuro violaceo con l’altra accosta delle uova sul piano. Buona la composizione ma per certe incidenze e per alcuni spazi vuoti non mi convince».
21 luglio: «ancora non trovo i rapporti di colori (sono sottili)»
23 luglio: «Piccole modifiche che mi risolvono credo, il quadro. Aggiunta di un panno chiaro vicino al vasetto. Migliorati i rapporti cromatici. La testa più che abbozzata è viva e mi piace».
26-27 luglio: «Riprendo la figura. Non trovo il modellato della guancia destra».
28 luglio: «Insisto su alcune parti, poco felicemente».
29 luglio: «Cambio la posizione della mano sinistra. Non vedo più il quadro».
30 luglio: «Riprendo la blusa, la mano la guancia. Mi adopero per terminare
Eseguo la n. m. con le uova. Non so giudicare; mi piace a momenti»[1].
Il giorno stesso del completamento del quadro, Mary Weiss lasciò Firenze: «Mary parte, sono triste e disorientato», scriveva Cavalli, rivelando così la tenerezza di un profondo legame affettivo. Alcuni mesi più tardi, il dipinto venne acquistato da Guido Weiss, come testimonia una lettera formale – curiosamente redatta in inglese, nonostante fosse solito comunicare in italiano con i suoi parenti – nella quale, oltre a confermare l’acquisto, autorizzava Cavalli a esporre l’opera nella sua prossima mostra[2]. Il dipinto fu effettivamente presentato nella personale allestita presso la Galleria Santacroce di Firenze, come attestano alcune fotografie dell’allestimento conservate nell’archivio dell’artista. L’esposizione, introdotta in catalogo da un testo critico del pittore Onofrio Martinelli, costituì la prima significativa personale di Cavalli a Firenze dopo quella del 1949 presso la Galleria Vigna Nuova. La mostra riscosse un buon successo e fu visitata da importanti personalità del mondo artistico e culturale italiano, tra cui Antonio Maraini, Vincenzo Balocchi, Adriana Pincherle, Mina Gregori e Lara Vinca Masini. Quest’ultima firmò sull’“Avanti!” una breve ma lusinghiera recensione, nella quale sottolineava come le opere dell’artista fossero «toccate magicamente da un soffio di pura poesia»[3].
Le parole dell’autrice attestano come una parte della critica italiana continuasse a seguire con interesse l’evoluzione della ricerca di Cavalli, anche in un momento in cui la sua partecipazione alle principali rassegne d’arte contemporanea si era fatta più diradata, certamente in ragione del suo ostinato attaccamento alla figurazione, ormai distante dalle tendenze dominanti. «Sono avvilito per quello che succede nel campo della pittura», scriveva il 4 giugno 1962; «Mi sembra di essere estraneo a tutto questo eppure vorrei che vi fosse interesse per il mio lavoro. Ho tenuto in febbraio una mostra antologica alla Galleria S. Croce. Ho avuto un buon riconoscimento. Ma sembra che io appartenga a un altro mondo. A questo mondo, ma già scomparso da molti anni…».
Manuel Carrera
[1] Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Fondi Storici, Fondo Emanuele Cavalli, serie 1 (Documenti personali), unità archivistica 3 (Diari), sottounità archivistica 2 [Diario (1961-1976)].
[2] Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Fondi Storici, Fondo Emanuele Cavalli, serie 2 (Corrispondenza), sottoserie 2 (Familiari), unità archivistica 19 (Parenti di Vera Haberfeld), sottounità archivistica 6 (Weiss Guido).
[3] L. Vinca Masini, Cavalli: umanità e poesia, in “Avanti!”, 28 gennaio 1962.
Per ulteriori informazioni, per acquistare o vendere opere di Cavalli Emanuele (1904-1981) e per richiedere stime e valutazioni gratuite
Tel +39 06 6871093
Mail info@carlovirgilio.it
Whatsapp +393382427650
oppure scrivici qui: